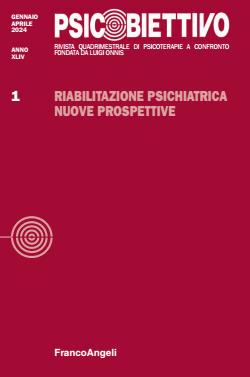
Il Centro Clinico-Psicologico di Cure Primarie IPAP-ASL TO4, nell’aprile 2020, ha avviato il progetto “Assistenza psicologica nell’ambito delle Cure Primarie per l’emergenza Covid-19: supporto alla persona, alle famiglie e alle comunità di aiuto”. Il progetto, presentato in risposta al Bando “Insieme tutto andrà bene” della Fondazione Compagnia di San Paolo e con il sostegno del Fon- do di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, ha integrato operativamente le iniziative messe in atto dall’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea (TO) attraverso l’implementazione dell’équipe psicologica per l’emergenza. Nel 2022, il progetto è stato insignito dalla Commissione Europea del 2021 EU Health Award (3° Premio), nella categoria ONG ed enti non-profit.


