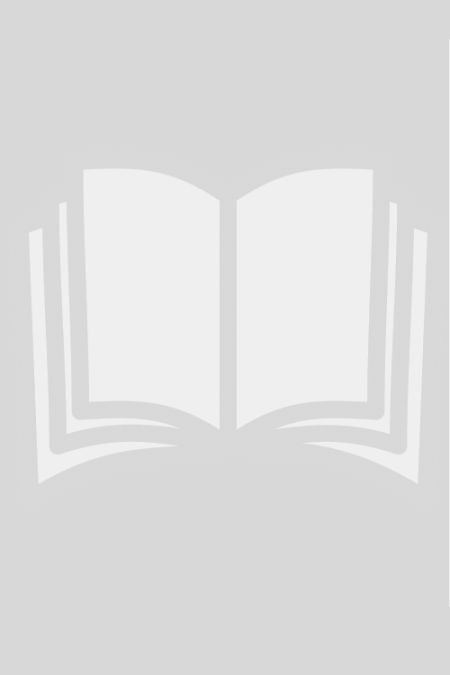
A cura di: Aurelio Bruzzo, Sylvie Occelli
Le relazioni tra conoscenza ed innovazione nello sviluppo dei territori
Pagine: 392
ISBN: 9788846471109
Edizione: 1a edizione 2005
Codice editore: 1390.37
Disponibilità: Discreta
CHIUSURA ESTIVA! Gli ordini di cartacei pervenuti entro il 27 Luglio saranno spediti entro il 1 Agosto. Torneremo operativi con le spedizioni a partire dal 25 Agosto. Buone vacanze!
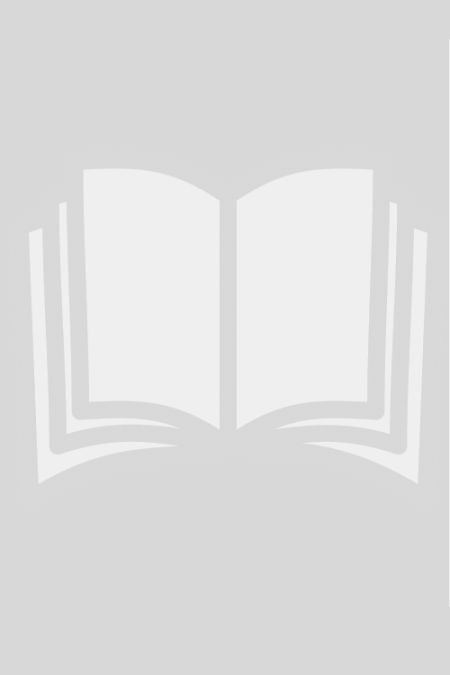
A cura di: Aurelio Bruzzo, Sylvie Occelli
Pagine: 392
ISBN: 9788846471109
Edizione: 1a edizione 2005
Codice editore: 1390.37
Disponibilità: Discreta
Contributi: Eliana Baici, Joana Barros, Michael Batty, Emilio Bellini, Filippo Bencardino, Paola Bolchi, Dino Borri, Carlo Boschetti, Roberta Capello, Valerio Cutini, Alessio D'Auria, Lidia Diappi, Simone Ferriani, Romano Fistola, Giovanni Fusco, Claudio Govoni, David A. Lane, Francesco Lapiana, Mario Maggioni, Cinzia Mainini, Andrea Morrison, Mario Nosvelli, Serena Pecori, Massimiliano Petri, Salvatore Rizzello, Paola Russo, Annalisa Sacconi, Luisa Santini, Alessandro Santucci, Paola Scala, Luca Scandale, Alves Junior Sinesio, Donatella Zotta
Collana: Scienze regionali
Argomenti: Economie locali, economia regionale
Livello: Studi, ricerche

Inserisci nel campo qui sotto il codice EAN (senza spazi) che si trova sotto il codice a barre sull'ultima pagina di copertina del libro che hai acquistato.
ATTENZIONE! Digita tutti i 13 numeri di seguito.