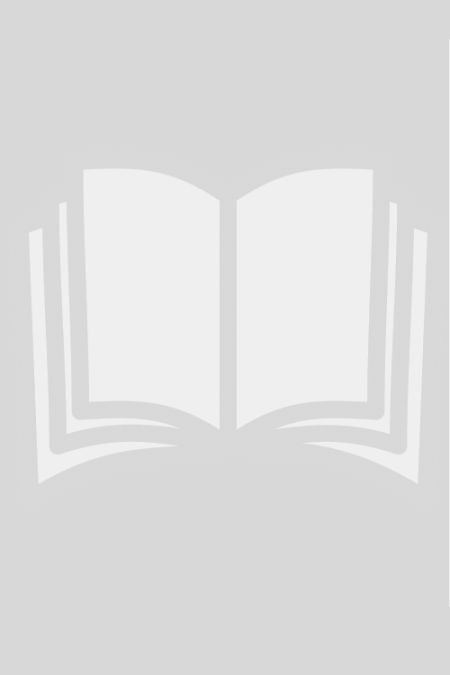
La validità come funzione dell'oggetto
Uno studio sul neokantismo di Heinrich Rickert
Pagine: 240
ISBN: 9788846475220
Edizione: 1a edizione 2006
Codice editore: 495.178
Disponibilità: Discreta
E-BOOK: our ebooks have changed DRM, what will happen now?
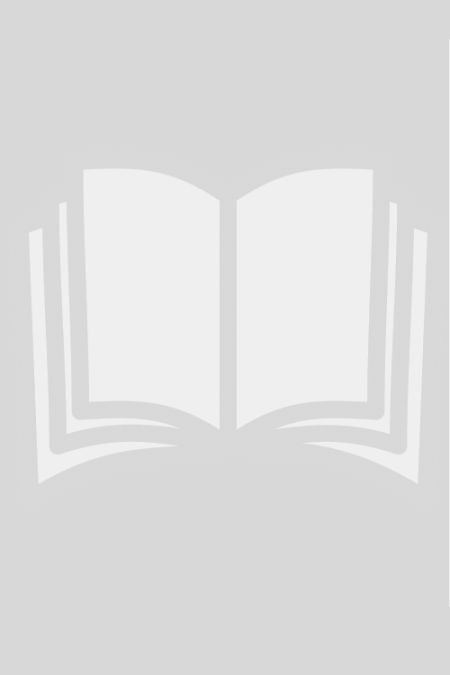
Pagine: 240
ISBN: 9788846475220
Edizione: 1a edizione 2006
Codice editore: 495.178
Disponibilità: Discreta