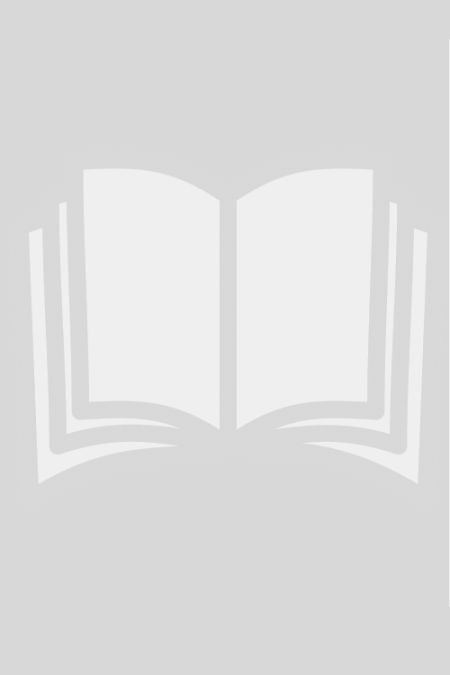
Il nome e le domande
Luoghi della soggettività nella "modernità riflessiva"
Pagine: 224
ISBN: 9788846425881
Edizione: 1a edizione 2001
Codice editore: 1520.349
Disponibilità: Discreta
CHIUSURA ESTIVA! Gli ordini di cartacei pervenuti entro il 27 Luglio saranno spediti entro il 1 Agosto. Torneremo operativi con le spedizioni a partire dal 25 Agosto. Buone vacanze!
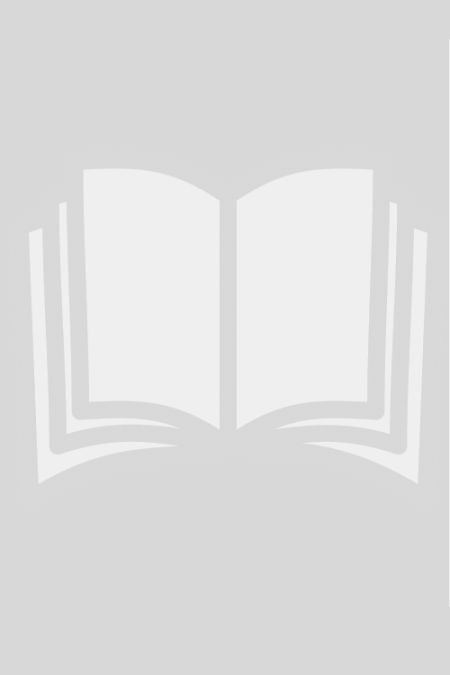
Pagine: 224
ISBN: 9788846425881
Edizione: 1a edizione 2001
Codice editore: 1520.349
Disponibilità: Discreta