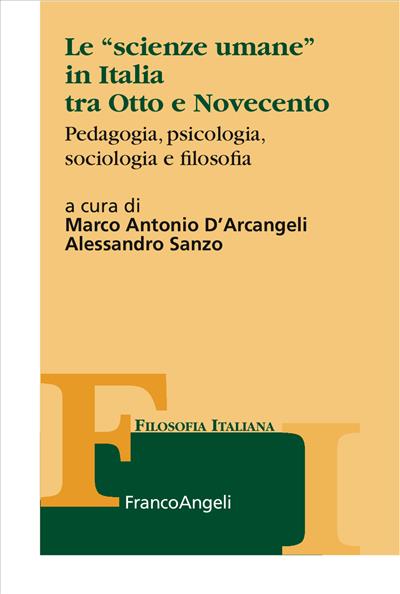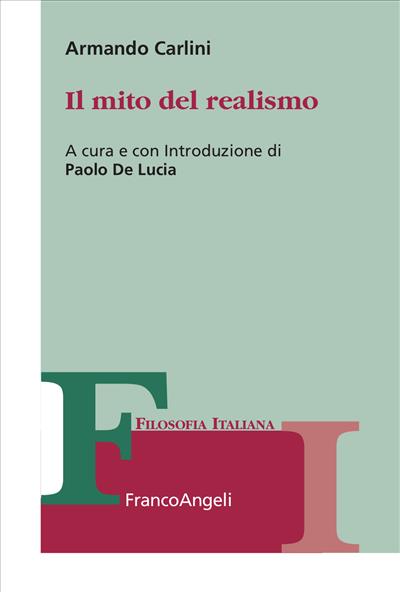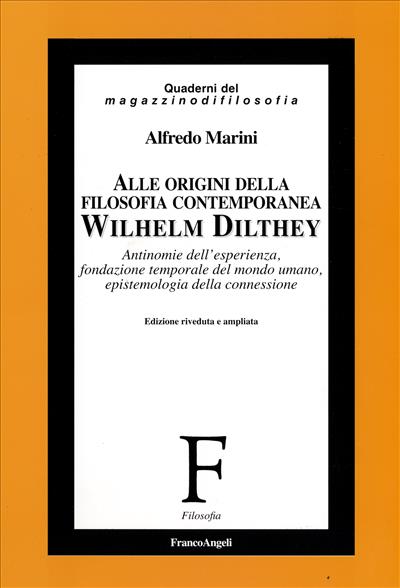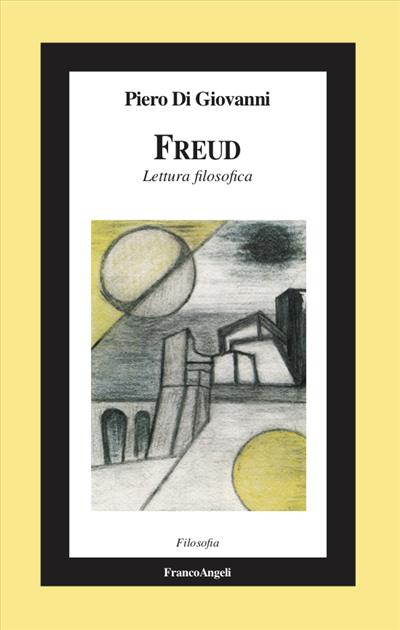Georg Misch
Dalla filosofia della vita alla logica ermeneutica
Edizione a stampa
27,50
Edizione a stampa
27,50
Pagine: 208
ISBN: 9788846431110
Edizione: 1a edizione 2001
Codice editore: 495.128
Disponibilità: Discreta